
Wituk è il colore della selva; quella più fitta e densa tanto da perdere l’orientamento. Quella che è al centro del mondo e di noi stessǝ. Bisogna trasformarsi in selva per entrarci, mimetizzarsi, assumere le stesse sembianze e gli stessi colori, odore e spirito. In questa trasformazione, il wituk è un alleato indispensabile.
Mani nere a ritmo di un tempo lento
Una mattina, io e alcune compagne del Servizio Civile, andammo a casa di Pakarina per farci dipingere con il wituk. Dopo vari mesi di vita in Ecuador, eravamo entrate in punta di piedi in alcune pratiche e conoscenze del territorio. Il trucco nero sulla fronte di alcune donne kichwa mi aveva da sempre affascinata, forse per la potenza che emanavano i suoi disegni di una simbologia ancestrale a me sconosciuta, o per la bellezza di questi volti, o forse per l’invisibile energia che veniva mostrata con dignità e spontaneità. Una donna che tutt’ora vive a Tena – la città dove abbiamo vissuto – ma di origine kichwa, Pakarina, ci ha permesso di accedere a questa conoscenza e di dipingerci il viso con il succo di questo frutto magico, steso con un ago dell’albero di limone. Questo è stato un privilegio e uno scambio di cui sono estremamente grata.

Ricordo tempi lenti e lunghi. Ricordo il suono della pioggia che scandisce il tempo e lo dilata nel suo scorrere, creando rigagnoli di terra che mi bagnano i piedi. Ricordo grandi foglie verdi trattenere l’acqua e rallentare il suo corso verso il suolo argilloso.
Il primo incontro con il wituk lo rivivo così, dettato dalla lentezza di una domenica piovosa. Pakarina ci accoglie nella sua casa, ai margini della città, ai bordi della foresta, non più primaria, ma sempre rigogliosa, Amazzonia nella periferia cittadina. Sembra un controsenso, ma non lo è. La sua casa è aperta, come quasi tutti gli edifici qui. La struttura è di legno, l’abitazione vera e propria è rialzata al primo piano, mentre sotto, dove stiamo noi, è tutto aperto ma coperto. Il terreno battuto accoglie i nostri piedi, sporchi di fango per via della pioggia.
Quando si vuole fare qualcosa in Amazzonia, la si fa da zero, seguendo tutto il processo. Ogni fase è importante e riveste un suo significato nel raggiungimento del risultato finale. Ho potuto sperimentare questo approccio in diverse situazioni legate all’uso delle piante, dal cibo alla cerimonia spirituale.
Accompagnate dalla conoscenza della nostra ospite, prendiamo il frutto ancora con la buccia giallina, lo annusiamo e lo laviamo. Poi con la grattugia, iniziamo il processo. Per ora sembra tutto normale, anzi, non ha un gran buon odore e non viene voglia di mangiarlo. E’ un inganno dei sensi, come tante volte accade in Amazzonia. La polpa del wituk è anch’essa giallina e il succo che rimane sulle mani è quasi trasparente… dopo una mezz’ora avviene la trasformazione. Come una bambina incredula ed estasiata, mi stupisco davanti a questa magia della natura. Tutte le mani diventano lentamente nere. Scientificamente è tutto provato: è il processo di ossidazione del succo, ma a me sembra una magia.

I mille volti del wituk
Si chiama wituk in lingua kichwa il frutto della Genipa americana, un albero originario della foresta pluviale amazzonica, diffuso in tutta l’America Centrale e Meridionale. Tra i popoli indigeni è conosciuto con molti altri nomi come huito, jagua, mayagua, bilito, guayatil, irayol, caruto, mandipa, genipap e jenipapo. L’albero può raggiungere fino a trenta metri di altezza, con una chioma ampia e ramificata. Il tronco è solitamente cilindrico e diritto, con una corteccia liscia di colore grigio, caratterizzata da macchie bianche. Le foglie sono ellittiche e si raggruppano alle estremità dei rami. I fiori, singoli, variano dal bianco al giallo e crescono in prossimità delle foglie. Il frutto, rotondo e carnoso, è di medie dimensioni ed esternamente ha un colore marrone-grigiastro.
Un ponte tra il mondo visibile e l’invisibile

Questa pianta riveste un ruolo fondamentale nella cultura di numerose comunità indigene che, attraverso i secoli, ne hanno tramandato i molteplici usi e significati. E’ un elemento profondamente radicato nella vita quotidiana e spirituale di questi popoli, un simbolo di identità e connessione con la natura, nonché dalle potenti proprietà medicinali. Le applicazioni del wituk sono varie e affascinanti. Il suo succo è estratto grattugiando il frutto che, a contatto con l’aria, si ossida e assume un’intensa tonalità blu-nera. Il liquido è utilizzato come tinta temporanea per decorare il corpo. Pur macchiando la pelle di nero in modo permanente, colpisce solo gli strati superficiali dell’epidermide, scomparendo entro circa due settimane con il naturale rinnovamento della pelle. Le decorazioni sul corpo seguono la simbologia indigena. Sono sempre diverse, spesso intricate e ricche di significato. Non sono solo una forma d’arte, ma tradizionalmente raccontano storie, appartenenze e ruoli all’interno della comunità. Nelle cerimonie rituali, il wituk si adopera come strumento per entrare in contatto con il mondo spirituale, trasformando il corpo umano in una tela vivente, creando una sorta di ponte tra ciò che è il mondo visibile e gli infiniti mondi invisibili. Per le comunità, il wituk non è solo una risorsa, ma un’entità viva e sacra. Nella selva, rappresenta la pianta – essenza stessa della vita: rigogliosa, potente e intrinsecamente legata al cosmo. I frutti e il succo nero contenuto in bottigliette di plastica si possono trovare occasionalmente al mercato di Tena, venduto da signore kichwa che lo utilizzano da secoli per diversi scopi.
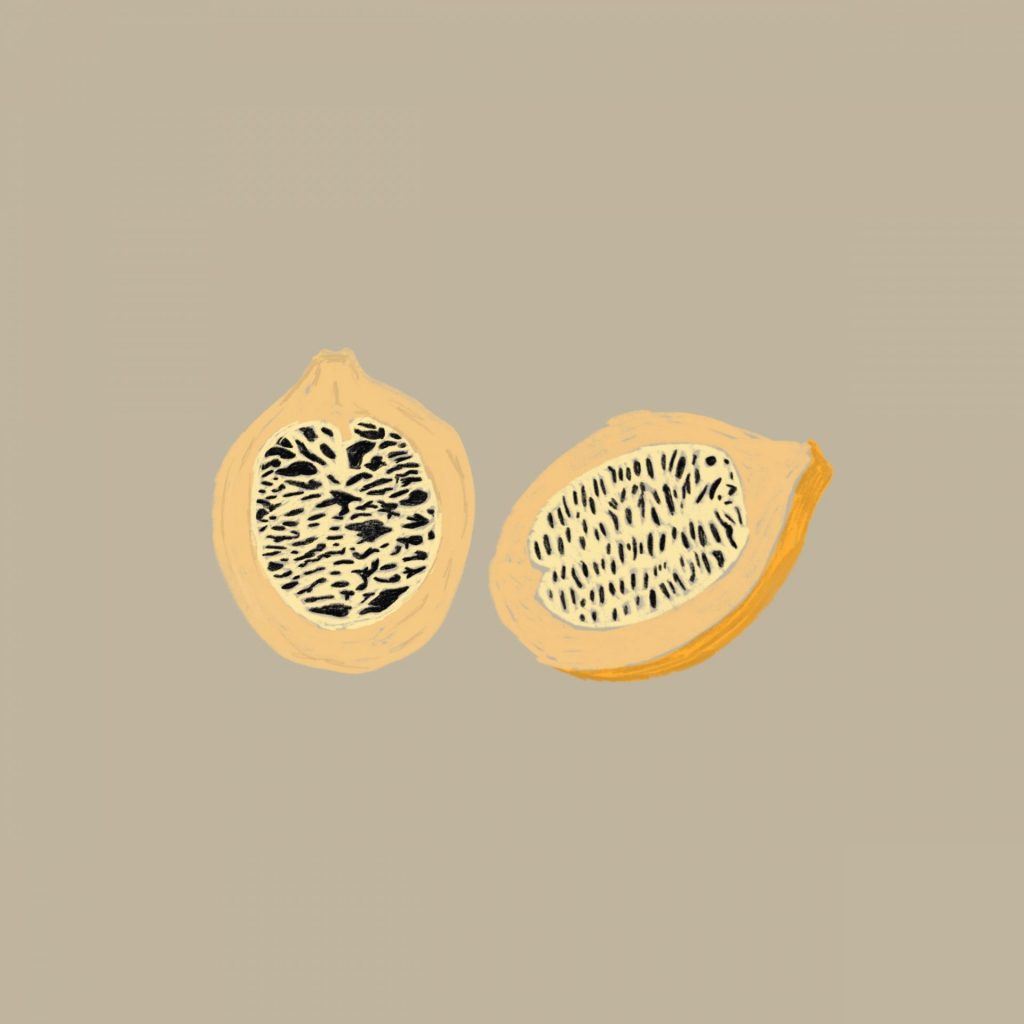
Chi è Pakarina?
Pakarina è una donna kichwa che vive a Tena. L’abbiamo conosciuta durante le uscite serali nei luoghi di aggregazione della città, quelli dove la cultura ancestrale e la socialità sono valorizzate nella lentezza e nello scambio. Lei conosce molte leggende orali della cultura kichwa e, come un libro parlante, capita di trovarla spesso con un microfono a raccontare, con voce calma e lo stile linguistico kichwa, le storie antiche della foresta. La incontriamo sempre con sua figlia che partecipa alle attività degli adulti nel suo modo da bimba, e spesso sono entrambe dipinte con il wituk. Il trucco è un segno evidente di qualcosa che vuole essere mostrato, di qualcosa di più profondo. La sua conoscenza e la visibile volontà di raccontare al mondo la sua cultura di origine, ci ha spinte a chiederle di parlarci del wituk, che cosa rappresenta per lei, per le donne e per la popolazione indigena.
Ci risponde così:
Nella nostra cosmovisione il wituk è una donna, warmi in kichwa. Per noi esiste un mondo spirituale che è legato alle piante, dove ogni pianta ha il suo spirito protettore. La wituk warmi ci fa questo dono. E’ un liquido che possiamo usare per dipingerci come trucco, nei nostri capelli, per darci felicità e forza. Se una donna è triste, allora si dipinge con il wituk e tutta la sua energia cambierà. Sarà più forte, più felice. Lo stesso vale per l’achiote1, perché entrambi ci danno i colori. Achiote e wituk, che sono considerate sorelle, sono i colori della giungla. C’è un’unione molto profonda di spiritualità tra ciò che sono le piante e ciò che siamo noi.
All’interno della comunità, il wituk significa energia, forza e, soprattutto, fa parte dell’identità culturale del mio popolo. Fino ad oggi è ancora praticato ed è molto importante non solo per le donne, ma per tutto il villaggio, per gli uomini, per i ragazzi, per le ragazze, per i nonni, per le nonne.
Attualmente, noi indigeni ci stiamo interessando a creare legami con la città, l’arte e la cultura urbana in Ecuador. Diciamo che anche nel mondo moderno il wituk sta iniziando a farsi conoscere, sia per il suo utilizzo sia come strumento di identificazione culturale.
Sentiamo il problema di aver subito una repressione culturale in termini di educazione, perché non ci potevamo dipingere, era proibito come un tabù, perché l’insegnante non ti faceva entrare a scuola se eri dipinta di wituk.
Oggi la situazione sta cambiando, soprattutto grazie alla questione dell’identità e dell’autodeterminazione delle popolazioni indigene. Quindi ora è più un momento in cui dobbiamo rafforzare le nostre conoscenze ancestrali e possiamo andare a scuola, all’università o a lavorare, usando la nostra pittura come parte della nostra identità.
Le donne indigene che lavorano nelle istituzioni pubbliche o che sono leader politiche mostrano la loro immagine al pubblico utilizzando i simboli kichwa, quindi anche il wituk.

È interessante come l’identità sia così strettamente connessa con questo tema. Che cosa significa per te identità?
Da un punto di vista occidentale e politico noi siamo Kichwa. Infatti, a livello politico e di organizzazione territoriale, la costituzione dell’Ecuador ci riconosce come popolo Kichwa, con la nostra lingua. Ma dall’interno, dal nostro territorio e dalla nostra cosmovisione ci riconosciamo come Runa (persona), parliamo Runa Shimi, e come il mio popolo io mi identifico Runa Warmi – donna.
Com’è iniziato il tuo rapporto personale con il wituk?
La mia prima esperienza con il wituk è stata con i miei cugini nella foresta, in una comunità lontana da Tena. In canoa a motore sono sei ore di viaggio sul fiume (in aereo sono circa 30 minuti) e si arriva in mezzo alla giungla, vicino al rio Bobonaza. Il fiume è lungo e passa attraverso diverse comunità, fino alla zona di Pastaza, dove c’è la mia famiglia.
Durante le vacanze andavo a trovare i miei cugini, e ogni volta che tornavo i miei capelli erano con il wituk, la mia faccia era dipinta. Quando tornavo in città, a Tena, avevo sempre la sensazione che i miei compagni di classe avrebbero riso. Mia madre, essendo una donna Kichwa, si dipingeva il viso, i capelli e le mani con il wituk ed eravamo l’unica famiglia di Tena, che aveva lasciato la comunità per essere coinvolta nella città, che continuava a dipingersi come una famiglia indigena. La scuola è una scuola occidentale e noi eravamo le uniche a dipingerci con il wituk e, grazie a mia madre, mi sentivo rafforzata, ma ero l’unica in classe, nessun’altro lo faceva.
Pensi che oggi invece rispetto ad allora qualcosa sia cambiato? Qual è secondo te il rapporto tra le giovani generazioni e le tradizioni ancestrali?
Negli ultimi anni, il legame tra i giovani e le conoscenze sulle piante medicinali ha vissuto un momento di rinnovamento, a seguito della pandemia di COVID-19. E’ importante il ruolo delle generazioni anziane nel trasmettere le conoscenze, anche se, nei quattro anni trascorsi dall’inizio del COVID abbiamo perso molti nonni e nonne che avevano conoscenze sulle piante. Quelli che sono rimasti e conoscono le piante medicinali le insegnano alle nuove generazioni, ad esempio come riconoscere un albero medicinale, quale parte dell’albero viene utilizzata, se la corteccia, le foglie o le radici.
Rispetto all’educazione, dall’altro lato, c’è l’Università IKIAM2, che è importante per quello che sta facendo in termini di ricerca, e rafforza anche la conoscenza tradizionale che abbiamo con le popolazioni indigene. Per me, queste due forme di conoscenza, l’educazione occidentale e la conoscenza ancestrale possono trovare un equilibrio tra loro e convivere tranquillamente.
C’è stato un cambiamento sociale, in termini di inclusione e diritto, da quando eri piccola ad oggi?
Sì,assolutamente. Negli ultimi anni, l’identificazione culturale ha avuto un impatto significativo sul modo in cui le comunità indigene si percepiscono e vengono percepite. Anche grazie ai diritti collettivi sanciti dalla Costituzione e al lavoro educativo nelle comunità, molti hanno potuto riaffermare la propria identità. Fino a qualche decennio fa, pratiche culturali come il dipingersi il viso con wituk erano motivo di derisione e discriminazione, nelle scuole e negli spazi urbani. La possibilità di autoidentificarsi come parte di un popolo indigeno rappresenta oggi una conquista. Questo diritto ha non solo rafforzato l’identità culturale, ma ha anche aperto la strada per altre forme di autodeterminazione, come quelle del gruppo LGBTIQ+, che trae ispirazione dai successi delle comunità indigene nella lotta per il riconoscimento. La strada verso un’inclusione completa è ancora lunga, ma i progressi ottenuti sono già evidenti e tangibili.
Ringraziamo di cuore Pakarina per essersi resa disponibile a condividere con noi la sua conoscenza e la missione di promotrice della cultura del suo popolo. La sua voce, tenace e combattiva, ci invita a riflettere sull’importanza di preservare le tradizioni ancestrali e di riconoscere il valore delle culture locali. Che ognuno ed ognuna di noi possa prendere coscienza e ripercorrere con consapevolezza il viaggio della cultura e delle tradizioni della propria terra, riscoprendo l’essenza delle radici che ci legano profondamente al mondo che ci circonda.
Le illustrazioni sono di Giuditta Furlan, grazie.



Lascia un commento